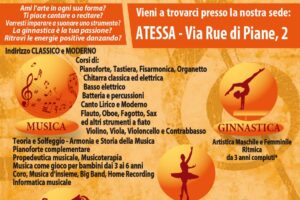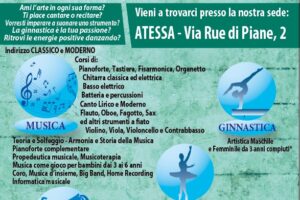Trovatori, Trovieri e Minnesaenger
Lo spirito di avventura che le Crociate avevano suscitato soprattutto nelle giovani generazioni, la morale cavalleresca e il culto della donna e dell’amore fecero nascere in Francia e in Germania un nuovo fertile e squisito genere di musica profana: la canzone.
Figli della nobiltà, cavalieri e uomini d’arme, non ricchi in quanto piccoli vassalli o figli cadetti senza terre né averi, cercavano la loro rivincita sociale nel cantare la nobiltà dell’animo contrapponendola a quella della stirpe. Sorretti da nuovi ideali, nomadi inquieti alla scoperta del mondo, avidi di fortune e di gloria, andavano di feudo in feudo e narravano novelle di guerre, di avventure, di amori e di gloriose imprese.
I temi ricorrenti delle prime canzoni dei trovatori erano la gioia, il risveglio della primavera, il culto della donna che, dall’ombra del suo esilio secolare, veniva innalzata a creatura ideale: questi temi anticipavano il grande successivo risveglio della poesia italiana.
Educati nei conventi e nelle scuole, dove l’insegnamento del canto liturgico era materia d’obbligo, i trovatori trasferirono nelle loro melodie i modi del canto gregoriano, introducendo però due elementi nuovi: il verso in rima e il ritmo misurato. Molte delle loro canzoni si prestavano infatti ad essere danzate; a volte sono persino invenzioni poetiche su motivi da ballo già esistenti.
Carta d’identità della canzone dei trovatori
La canzone trovadorica presenta le seguenti caratteristiche:
come il canto gregoriano è monodica;
come il canto gregoriano è modale;
può essere accompagnata da strumenti;
a differenza del canto gregoriano, ha ritmo misurato, talvolta molto ben scandito, il testo è in versi;
la melodia precede anche per intervalli ampi;
la melodia si sviluppa entro un’estensione ampia;
il testo è in lingua volgare;
la canzone è divisa in sezioni, spesso in forma di rondò.
I termini trovatori e trovieri derivano dal francese troubadours e trouvères che a loro volta sembrano derivare dal latino tropare, tropum invenire, vale a dire “tropare, scoprire, fare tropi”, creare versetti, inventare prose ritmiche. Il tedesco Minnesaenger significa invece letteralmente “cantore, poeta d’amore”.
Le canzoni dei trovatori – originari della Provenza, nella Francia meridionale – erano di genere lirico, ispirate soprattutto all’amore, alla idealizzazione della donna e alla poesia della natura. Quelle dei trovieri invece – fiorite nella Francia settentrionale – erano di genere epico-narrativo, dedicate soprattutto alle gesta dei cavalieri e a episodi gloriosi delle Crociate. I Minnesaenger a loro volta coltivavano un genere sia lirico sia epico. Questi movimenti ebbero una grande diffusione, estendendosi in breve tempo oltre i Pirenei, in Spagna e in Portogallo, dove i conquistatori arabi avevano introdotto i modi squisiti della loro poesia e della loro musica, e a nord, in Inghilterra, destinata a divenire patria di re trovatori e trovieri, tra i quali il celebrato Riccardo Cuor di Leone.
Celebri trovatori furono Guillaume de Poitiers (1071-1127), Jaufré Rudel (1141) – il cui leggendario amore per Mélisende, la Contessa di Tripoli, ispiro una famosa poesia a Giosuè Carducci – e Raimbaut de Vaqueiras (1207).
Fra i trovieri spiccano Riccardo Cuor di Leone (1157-1199), Adam de la Halle,(1237-1287) – autore tra l’altro di un famoso jeu, Le jeu de Robin et de Marion – e Guiraut Riquier (1230-1294).
Grandi Minnesaenger furono Witzlaw von Rugen (1325), Walther von der Vogelweide (1170-1230) e Wolfram von Eschenbach (1220).
Trovatori, trovieri e Minneseanger oggi potrebbero anche essere chiamati cantautori. Pur traendo talvolta spunto da melodie e danze popolari il loro stile era però raffinato ed elegante.
Con la canzone si ha un primo timido accenno di musica strumentale; trovatori e trovieri si facevano infatti accompagnare da uno o più “giullari” – jougleurs – che suonavano il liuto o la viella, e compaiono allo stesso tempo anche le prime forme musicali nel senso moderno della parola:
Ballata o canzone a ballo: come dice il termine, era destinata alla danza; la ballata era costruita su una o più stanze con un ritornello, detto ripresa, che veniva cantata in coro.
Compianto: canzone funebre in elogio di un defunto illustre.
Contrasto o tenzone: stornelli a due voci in forma dialogata; i due personaggi potevano essere reali o allegorici.
Maggiolata: canzone inneggiante la primavera.
Pastorella: canzone a carattere pastorale e agreste; questo compimento poetico aveva metrica molto varia.
Sirventese: canzone di ispirazione politica, moraleggiante e religiosa.