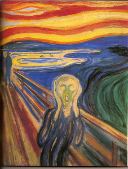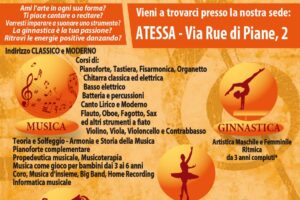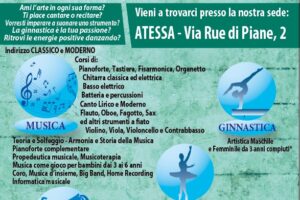Il ventesimo secolo e la musica moderna
L’aspetto più impressionante nella storia dell’Occidente, a partire dal Rinascimento in poi, è il prodursi di una serie di cambiamenti continui e progressivi. Tali cambiamenti si susseguono dapprima lenti, poi sempre più rapidi per giungere, nel ventesimo secolo, un’accelerazione inaudita. In questo periodo si verifica un numero impressionante di grandi scoperte e si realizzano altrettante importanti imprese che aprono nuovi orizzonti alla vita dell’uomo: dal primo volo dei fratelli Wright agli esperimenti di Guglielmo Marconi, dal volo orbitale di Yuri Gagarin all’esplorazione lunare di Neil Armstrong , dalla scoperta della penicillina ai trapianti cardiaci fino alle frontiere inesplorate dell’ingegneria genetica, il nostro mondo ha compiuto in meno di cento anni un rivoluzione scientifica, tecnica e sociale senza precedenti.
Tra le conseguenze di tali cambiamenti, la più spettacolare è la crescente “dinamizzazione” del vivere umano. Si produce e si consuma sempre più in fretta, si vive in mezzo a una miriade incalzante di stimoli, di interessi, di idee, di impegni. Una pubblicità massiccia e assillante sollecita e amplifica il bisogno di nuovi consumi, inculcando la convinzione che il “meglio” è soltanto ciò che è “nuovo”. Nel campo musicale, nuovi strumenti, frutto delle ultime conquiste tecnologiche, si sono aggiunti all’armamentario del compositore. L’elettronica ha ampliato incredibilmente la gamma dei suoni, di timbri e di effetti disponibili, aprendo un orizzonte pressoché illimitato di possibilità. Lo stesso computer è in gradi di assistere il musicista nell’analisi e nella sintesi dei suoni, nell’analisi musicologica, nell’esecuzione e nella stampa di partiture e persino nella stessa composizione.
Dal tonale all’atonale
Si fa coincidere la nascita della musica moderna con la prima esecuzione del poema sinfonico Prélude à l’après-midi d’un faune di Claude Debussy (1862-1918) avvenuta a Parigi nel 1894. Con Debussy il sistema musicale fondato sulla scala diatonica riceve la prima scossa. Ricompaiono non solo i modi greci, ma vengono introdotte anche le scale esotiche della musica orientale, col risultato che armonia e melodia acquistano un carattere assolutamente nuovo. La tonalità è indefinita, la distinzione fra consonanza e dissonanza diviene meno netta, gli accordi a se stanti senza relazione fra loro, mentre tutto il discorso musicale si sviluppa in un’atmosfera vaga e sospesa.
La Sagra della Primavera di Igor Stravinskij (1882-1971) presentata a Parigi nel 1913, apre una svolta decisiva. Con le sue scatenate sovrapposizioni di accordi appartenenti a tonalità diverse (politonalismo), con l’insolito, concitato linguaggio ritmico determinato da un succedersi irregolare e imprevedibile di misure diseguali e gli inauditi effetti timbrici, La Sagra rappresentò al suo apparire la più radicale rottura con il passato. La reazione del pubblico parigino, colto di sorpresa, fu clamorosa: l’esecuzione fu portata a termine nel bel mezzo di un memorabile pandemonio. Era chiaro che quest’opera apriva un solco incolmabile con il linguaggio della musica tonale che per tre secoli aveva prodotto i più grandi capolavori musicali.
La musica de La Sagra – politonale – manteneva sempre un sia pur remoto riferimento alla tonalità. Il suo abbandono totale e definitivo fu operato negli stessi anni da Arnold Schönberg (1864-1915) con il suo poemetto Pierrot Lunaire, una serie di brevi miniature per voce solista e piccolo complesso da camera. Abbandonate le grandiose sonorità della grande orchestra, Schönberg ritorna ad un linguaggio essenziale affidato a un ristretto organico di esecutori. La musica si sviluppa liberamente nell’ambito delle 12 note della scala cromatica. Scomparsa la tonica, abolita ogni distinzione tra consonanza e dissonanza, al loro posto compare un nuovo illimitato campo di combinazioni di suoni. La voce, a sua volta, non canta nel senso tradizionale della parola, ma “recita”, in una sorta di parlato-cantato che Schönberg battezzò Sprechstimme, oscillante tra toni indefiniti.